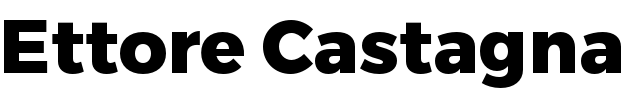Il mango, il son ed una vecchia Lada quasi amaranto
Note a margine di un viaggio a Cuba nel 1997
(World Music, Roma, n. 34, ottobre 1998)
di Ettore Castagna
Al Vedado o, più lontano, al rione Vibora… ma pure nel cuore della vecchia Habana coloniale mi piace pensare che nella casa di ogni nero c’è un altare di Babalè-ayè. È certamente un altare colorato da piccole offerte e candele. Un altare santèro, custode del mistero Yoruba. Ramiro, il nostro autista, un geologo con gli occhi da indio, è da tempo, oramai, disoccupato e si guadagna da vivere facendo l’autista per gli stranieri. Nella congerie della carestia da embargo americano, una sindrome economica che qui si chiama periodo especiàl, tutti i cubani si arrangiano. L’isola manca di tutto.
Ramiro è il nostro nocchiero sulle avenidas dell’Habana e sulle carreteras dell’interno. È oramai un capitano di lungo corso a bordo della vecchia Lada made in U.S.S.R. con circa quattrocentomila chilometri sul gobbo e che ha ereditato da suo padre. A Cuba le macchine non si comprano, si ereditano. Ci sono carros americanos degli anni trenta ancora in circolazione. Quando ci chiediamo sbalorditi come fanno a tenerle insieme dopo sessant’anni e senza pezzi di ricambio Ramiro ridacchia, tira su il volume dello stereo e grida, sul ritmo del danzòn, “Aquì no tenemos mecanicos… tenemos màgos!” Navigheremo insieme per Cuba per qualche tempo. Da Santa Clara a Pinàr del Rio, da Camaguey fino forse a Guantanamo. Andremo a Guantanamo? Forse a spiare da lontano le fotoelettriche perfette della base yankee mentre in tutta Cuba la luce manca. Manca perché il petrolio non basta e c’è l’embargo. Si spengono di colpo i ventilatori come i frigoriferi e si aspetta in silenzio, con quaranta gradi e l’umido dei tropici a cavallo del naso, che Fidel riattacchi la corrente dopo un indeterminabile black out per risparmiare energia. Cuba sembra mia zia Bettina buonanima: allegra, ospitale e grande cuoca. La sera però non accendeva la luce fino a tardi perchè vivere con la pensione insegna a risparmiare. Mia zia Bettina ballava alla perfezione il tango figurato sulla spinta dei suo gracchiante 78 rpm ma il perìodo especiàl per lei, come per diversi nel nostro Sud, è durato tutta una vita.
Ramìro il tango figurato non sa cos’è ma in compenso conosce i Van Van “… no hay al mundo un mejor conjunto de salsa”. Poi ci spiega che, proprio come in certi discorsi dove è più importante ciò che non si è detto, a Cuba il ballo più vero, quello più all’antica è fatto di piccoli movimenti, quasi inattesi. Non si balla per somma ma per sottrazione. Il moto della danza si divincola con la velocità lenta di un serpente a caccia fra gli sterpi: piano o prestissimo ma in spazi brevi. I piedi rimangono pressoché uniti. All’opposto di quanto si potrebbe pensare, è l’anima che scende a possedere il corpo. Non sono le forze ctonie della terra o i flussi della stessa carne. In fondo, evangelicamente, la carne potrebbe essere troppo debole per tutto ciò. Una tale possessione fa emettere radiazioni inafferrabili. Dal pube si leva una colonna d’aria che sconvolge il cielo in battere e la terra in levare. Così ballavano gli schiavi Yoruba. Così ballavano perché avevano i ceppi ai piedi. I ceppi e le catene che non permettevano larghi passi. Ma, a quel che pare, per chi sente la danza come una necessità dell’anima, i ceppi non sono un adeguato deterrente. Questo è quello che mi viene sempre in mente quando, ogni tanto, mi scivola via sullo stereo il velluto sincopato del Trio Matamòros .È un cd di incisioni, direi, d’epoca. In controluce, fra le voci languide e perfette, si intravede l’ombra diafana di una Cuba hemingwayana, straziata di sigari e ron e sesso maledetto sul ventre di una mulatta. L’ho comprato in aeroporto rinunciando alla maglietta con il Che Guevara e non me ne sono poi pentito. Eppure, si dice, oggi all’Habana non è così facile ballare come una volta. Ballare per davvero voglio dire. Tutte le sale da ballo sono inondate di jineteras in cerca di clientela (Jineteras, in italiano “cavalcatrici”, ragazze che cercano di attraversare il periodo especiàl ottimizzando le risorse dell’Antica Virtù) e vige una sorta di apartheid del dollaro. Ramiro ci porta a vedere “El Medico de la Salsa”, una band di grande spinta che farebbe ballare anche un hot dog. Ma la situazione è desolante, è un grande luogo aperto di cui ho poi rimosso il nome… una specie di carcere. Su una terrazza lontana dal palco ma ben chiusa da cancelli e fornita di bar, per dieci dollari a testa possono accedere los turistas. In fondo, a cinquanta metri, accatastati come mosche, a migliaia, tutti i cubani che per pochi pesos sono ammessi a ballare. Ma sono troppi, sono sempre di più. Dentro il recinto, come animali pressati ed ubriachi. Qualcuno leva il coltello o spacca per terra una bottiglia. Volano calci e pugni. Questo è sufficiente per intristire il mio dio personale e ridente del ballo afro-cubano. Tutto calmo invece è il clima nella nostra gabbietta dorata dove i tavoli pullulano di jineteras in compagnia di turisti maschi in prevalenza italiani e spagnoli. Altrettante ce ne sono a caccia di clienti. Ballano in modo vistoso per farsi notare. Ramiro scuote la testa, le jineteras lo intristiscono ma lo rende ancora più triste veder ballare in questo modo. Dice che sono scopiazzature del Samba, fatte solo per vendere la merce. Il baile cubano è “otra cosa”. Sta di fatto che questo non ci pare un luogo divertente. Ramiro por favòr portaci da un’altra parte… a bere un Mojito alla Bodeguita del Medio affollata di canadesi e di tedeschi impazienti di trovare le foto di Hemingway con Fidèl appese accanto al banco. Oppure portaci a passeggiare sul Malecòn, coi lampioni dell’Habana vecchia illuminata nella notte e milioni di zanzare assetate ad attenderci. Amano il nostro sangue quanto noi amiamo il Guarapo appena spremuto da una canna da zucchero. Magari con qualche cubo di ghiaccio.
La Lada quasi amaranto di Ramiro è un inarrestabile carroarmato sovietico. Non teme gli sterrati di campagna né le grosse radici che spuntano come trappole dal terreno, non teme di sguazzare nel puntuale acquacèro tropicàl, il temporale impressionante che si abbatte con regolarità quasi mitteleuropea, ogni due o tre ore, scaricando i troppi vapori del cielo a questa latitudine. Nel cofano c’è di tutto: bidoni di benzina di riserva, corde, pala e altri attrezzi, cappellini da spiaggia, cinque o sei chili di mango appena colto. A Cuba ci sono decine di tipi di mango diverso: il mango señora, il mango corazòn, il mango platanìto e così via. Sono tutti infinitamente buoni, da mangiarne a chili senza saziarsi mai. Ed è così che finiamo in una campagna intorno a Trinidàd, a casa di contadini amici di Ramìro. Lui sa che amiamo il mango ed ecco qua. Un’intera piantagione di mangheras gigantesche da scuotere con qualche ciottolo ed aspettare che un frutto grosso e succoso cada giù.
Sembra un fumetto. C’è un contadino che fischietta “Guantanamera” ed accudisce i porcellini gialli, quelli rosa e quelli neri. Poi le ochette, le galline, i pulcini, i tacchini e tutto il resto qua, qua, qua…. È un eden agro-tropicale sotto gli alberi e le palme. Ma il colpo di grazia è il cane che prima gioca con noi e poi pasteggia con le scorze di mango che gli lanciamo. Potenza dei Caraibi! Io prima conoscevo solo cani carnivori.
Per tornare alla sonosfera, una bella esperienza acustica arriva quando la padrona di casa ci invita a bere il caffè. I chicchi verdi spuntano frusciando da un sacco, vengono tostati scoppiettando a fiamma viva e dopo messi in un grosso mortaio e pestati. Si dice machucar ed è un’azione dal suono sordo che fa vibrare tutta la terra intorno. Fa ogni cosa questa donnina, magra e minuta, che è la padrona di casa. Per meglio dire “di capanna”. Alza e abbassa il grosso batacchio del mortaio e polverizza il caffè in pochi secondi, con una precisione tutta contadina. Con la forza incontenibile di chi ha faticato una vita intera, ha faticato così tanto senza potersi mai permettere il lusso irragiungibile di provarla la stanchezza, di chi sa come si abbatte il machete sulla canna e quanto costa ogni movimento gravato dal sole di queste latitudini. Nel frattempo bolle l’acqua ed, altrettanto velocemente, dalla polvere nera viene fuori un infuso saporoso e profumato addolcito con il mitico zucchero di canna cubano. Il miglior caffè di casa vostra sta a questa ambrosia come una focaccetta surgelata alla pizza assaggiata direttamente da qualche specialista a Mergellina.
Come dice Ry Cooder “…in Cuba the music flows like a river”. Ma non si fa tardi nell’accorgersene. La maggior parte dei locali, per quanto scalcinati, dispone di almeno tre o quattro musicisti per allietare il pubblico. Forse non tutti sono bravissimi ma la quantità di quelli di ottima levatura è assolutamente inverosimile. Proprio come il numero delle zanzare sul Malecòn al tramonto mentre all’orizzonte si vedono i lampi della tempesta sull’oceano in direzione della Florìda.
C’è l’imbarazzo della scelta: fiatisti cristallini di una sinuosità pari alla dolcezza della Guayaba, chitarristi caleidoscopici, percussionisti di elasticità felina. La conga si mantiene fra le gambe come un fallo eretto, come il membro imponente di un’orchestra genitale. Da queste parti la carnalità non genera angoscia, turbamento, grottesca bavosità o senso di colpa come spesso nella vecchia Europa. La vergogna del corpo da noi è un fatto genetico. Qui non ci pensano nemmeno.
Anche Ramiro forse crede che la vita sia un Bolero o un Son. Non so. Ho scoperto però almeno due cose che ci accomunano.
La prima è che per dormire ai tropici abbiamo entrambi bisogno del ventilatore acceso tutta la notte.
La seconda è un viaggio di ritorno da Santa Clara. Io e Chiara parlavamo dell’ultima lettera del Che a Fidèl prima di partire per la Bolivia, quella famosa che si può leggere anche impressa sul marmo dell’ecclesiale mausoleo dedicato al guerrillero heroico. Ne parlavamo accoratamente. Ramìro ci ascoltava in silenzio, guardava lontano attraverso il parabrezza, i tergicristalli e l’acquacero tropical, forse scopriva di capire l’italiano. Ad un certo punto ci siamo tutti vicendevolmente sorpresi i lucciconi agli occhi. Ma lo abbiamo solo notato a margine, con la discrezione di una farfalla. Non ce lo siamo reciprocamente confessato. Perché non era necessario.
Spesso, anche negli archivi immateriali della memoria, i sentimenti finiscono per smarrirsi. Di quella volta, almeno, ricorderemo che la tenerezza rimase, per sempre, agli atti del nostro cuore.